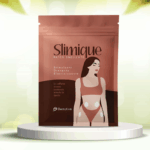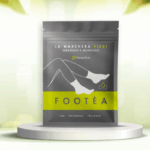Gli esperti di inquinamento atmosferico utilizzano una combinazione di metodi diretti e indiretti, adottando soluzioni tecnologiche avanzate per monitorare e quantificare la presenza di sostanze inquinanti nell’aria. Il motivo principale di questa varietà di approcci è la necessità di coprire un ampio spettro di inquinanti, dalle polveri sottili ai gas tossici e ai composti volatili, e rispondere agli standard richiesti dalla normativa europea e nazionale.
Principali inquinanti monitorati
La misura dell’inquinamento atmosferico si concentra su alcune categorie di inquinanti prioritari, in base alla loro incidenza sulla salute umana e sull’ambiente. Tra questi spiccano il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), il biossido di azoto (NO2), il monossido di carbonio (CO), l’ozono (O3), il biossido di zolfo (SO2) e i composti organici volatili (COV).
La particolare attenzione è dedicata alle polveri sottili, classificate secondo il loro diametro aerodinamico: PM10 (diametro ? 10 µm) e PM2.5 (diametro ? 2,5 µm). Questi inquinanti sono responsabili di effetti nocivi sulle vie respiratorie e sono soggetti a regolamentazioni stringenti.
Metodi diretti di misura
I metodi diretti rappresentano la modalità standard con cui gli enti di controllo, come ARPA, misurano la concentrazione degli inquinanti nell’aria. Questi si basano su strumenti installati in stazioni di monitoraggio fisse o mobili, che acquisiscono dati in tempo reale e, in alcuni casi, permettono anche campionamenti periodici.
Metodo gravimetrico
Per la determinazione del particolato atmosferico, il metodo gravimetrico rappresenta il sistema di riferimento. Esso consiste nel raccogliere l’aria su filtri specifici, che vengono poi pesati prima e dopo l’esposizione, per calcolare la massa delle particelle depositate. Il procedimento avviene in condizioni controllate di temperatura e umidità. La norma tecnica EN 12341:2014 stabilisce i dettagli applicativi di questo metodo, garantendo uniformità e precisione delle misure.
Nel contesto moderno, spesso si ricorre anche a strumentazioni automatiche, certificate come equivalenti al metodo gravimetrico. Un esempio è la misura delle polveri sottili mediante l’attenuazione della radiazione beta: le particelle raccolte su un nastro filtrante assorbono la radiazione, diminuendone l’intensità rilevata da un sensore, da cui si ricava la concentrazione delle polveri.
Spettrometria e fluorescenza
Per determinare la presenza di gas inquinanti, come il biossido di zolfo e il biossido di azoto, si utilizzano tecniche basate sull’analisi delle proprietà ottiche delle molecole. Il metodo a fluorescenza per SO2 si fonda sull’assorbimento di radiazioni ultraviolette da parte delle molecole di ossido, che emettono segnali luminosi proporzionali alla concentrazione del gas.
La spettrometria UV e la chemiluminescenza sono largamente impiegate per l’analisi degli ossidi di azoto e dell’ozono, sfruttando la diversa risposta luminosa dei composti analizzati.
Strumentazione avanzata
Tra gli strumenti di ultima generazione si annoverano le apparecchiature Lidar (Light Detection and Ranging). Queste sfruttano impulsi laser emessi dal suolo verso l’alto: analizzando il segnale ritornato, si ricostruiscono i profili verticali degli inquinanti atmosferici e degli aerosol non gassosi, con risoluzione fino a pochi metri e copertura fino a oltre 15 chilometri di quota.
Le analisi lidar permettono di individuare fenomeni di trasporto a lunga distanza e stratificazioni particolari, utili in studi avanzati di qualità dell’aria.
Metodi indiretti e modellistica
Non tutti gli inquinanti possono essere monitorati in tempo reale o sono economicamente sostenibili con metodi diretti. Perciò vengono spesso affiancati dai modelli di stima e simulazione, che svolgono un ruolo cruciale nella gestione delle politiche ambientali.
Il primo passo per applicare tali modelli è la raccolta dei dati tramite inventari delle emissioni, che catalogano le fonti e le quantità di agenti inquinanti emesse da attività industriali, traffico, riscaldamento, processi naturali o accidentali. A partire da questi dati, si impiegano modelli matematici per stimare le concentrazioni degli inquinanti dove le misure mancano, oppure per prevederle in scenari futuri.
Modelli di dispersione
I modelli di dispersione atmosferica elaborano le informazioni relative alle condizioni meteorologiche, alle fonti di emissione e alla topografia locale per simulare la distribuzione e il movimento degli inquinanti. Gli approcci principali sono:
- Modelli gaussiani, come AERMOD, adatti a rappresentare pennacchi continui di sostanze inquinanti, ideali per centri urbani e aree industriali.
- Modelli a nuvola (puff models), come CALPUFF, che simulano il movimento e la trasformazione di singoli “banchi” di contaminante, offrendo maggiore dettaglio in aree complesse o per emissioni disomogenee.
Questi strumenti sono fondamentali per valutare l’efficacia di politiche di contenimento dell’inquinamento e per confrontare i risultati della simulazione con gli standard sulla qualità dell’aria fissati dalla normativa.
Monitoraggio diffuso e strumenti portatili
Oltre alle stazioni fisse e alle simulazioni numeriche, si sta progressivamente affermando l’uso di strumentazione portatile e sistemi low cost per il controllo della qualità dell’aria in ambienti interni ed esterni. Tra questi spiccano:
- Centraline microclimatiche, in grado di registrare parametri ambientali e concentrazioni di polveri e gas nocivi.
- Sensori specifici per il rilevamento di polveri sottili, ideali per la sorveglianza capillare in quartieri urbani o in prossimità di fonti di emissione come strade trafficate.
- Rilevatori multigas, utili per l’analisi rapida di ambiente e la protezione di lavoratori esposti.
Questi dispositivi, seppur meno precisi delle centraline istituzionali per quanto riguarda la verifica degli standard di legge, sono preziosi per studi preliminari, campagne informative e controllo in aree non coperte dalla rete ufficiale di monitoraggio.
L’importanza dell’integrazione dei dati
L’approccio moderno al controllo dell’inquinamento atmosferico si basa sulla sinergia tra metodi diversi. I dati provenienti da stazioni di monitoraggio automatico, modelli numerici di simulazione e sensori diffusi devono essere integrati tramite sistemi informatici avanzati. Solo attraverso questa integrazione è possibile ottenere una visione completa e dettagliata sia della situazione attuale che delle evoluzioni future del fenomeno. Oltre a fornire informazioni ai cittadini, questi sistemi supportano le decisioni delle amministrazioni per la gestione delle emergenze e la pianificazione territoriale.
Il risultato finale è una mappatura dinamica e aggiornata delle concentrazioni di inquinanti in aree urbane e rurali, che consente di identificare zone critiche, valutare esposizioni individuali e proporre soluzioni mirate. È proprio l’innovazione tecnologica, insieme al rigore scientifico, a garantire oggi una misurazione sempre più precisa e tempestiva dell’inquinamento atmosferico.